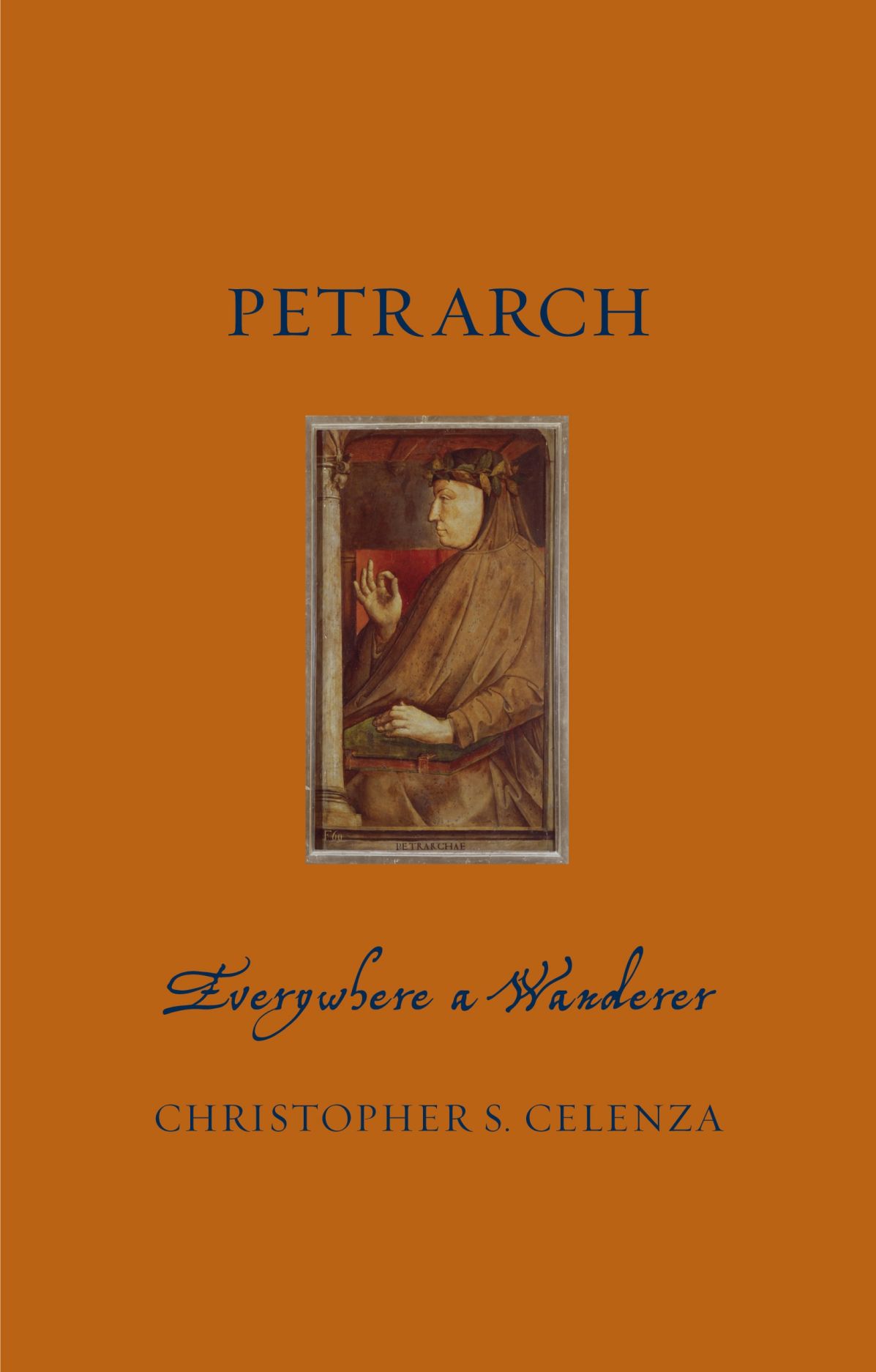Riproduco qui gli ultimi due capitoli della mia tesi su “Forma e stile della narrazione saramaghiana“, da poco completati, sperando di far cosa gradita. Purtroppo bisogna avere un po’ di familiarità col portoghese per intendere i passaggi in lingua originale. Ecco la Conclusione e i Ringraziamenti.

CONCLUSIONE
Nel suo lungo viaggio, personale e letterario, Saramago ha tracciato le linee guida di un percorso che abbiamo visto snodarsi sotto varie forme, da quelle canoniche del periodo di formazione a quelle sperimentali della produzione adulta. Per segnalare l’apertura e la chiusura di ciascuna fase ci siamo serviti di riferimenti temporali che lo stesso autore riconosce come spie di un cambiamento nel suo modo di scrivere. Il periodo di formazione abbraccia quasi tre decadi, mentre la fase sperimentale si sovrappone al periodo precedente (parte per intenderci già dal Manual de Pintura e de Caligrafia) per chiudersi con Caim, cioè con l’ultimo romanzo compiuto, e si divide a sua volta in due sotto cicli (la Statua e la Pietra), il cui momento spartiacque si colloca sicuramente – per indicazione dell’autore – tra O Evangelho segundo Jesus Cristo e l’Ensaio sobre a Cegueira. Si tratta di cerniere temporali importanti, poiché oltre a permetterci di fissare dei paletti lungo una parabola di quasi settant’anni, ci danno la possibilità di scandire la maturazione cogitans ed extensa del suo pensiero e del suo punto di vista sulle cose. Ad ogni modo, parlare di punto di vista vuol dire, nel caso di Saramago, usare un termine troppo generico e quindi inadatto a riassumere concetti ben più circoscritti quali ideologia e interpretazione della letteratura. Abbiamo visto come, specie nel tragitto conclusivo, i due aspetti coincidano e si crei nella scrittura un amalgama perfetto tra le idee ereditate dal marxismo e l’applicazione di una serie di principi artistici che spaziano dalla corrente neorealista luso-brasiliana al simbolismo francese, dal surrealismo di Dalì al barocchismo di Padre Vieira e Almeida Garrett, dal post avanguardismo palese di O Ouvido e O Ano de 1993 al materialismo visivo di Mantegna; per non parlare del sostrato culturale profondo, percepibile a livello progettuale, di ciò che Saramago aveva appreso tramite la storiografia francese delle Annales e messo in pratica nei romanzi di impronta storica (George Duby e Le Goff sono cruciali per il suo modo di intendere il passato[1]); ma anche da Alexandre Herculano, più volte citato e riconosciuto come mentore[2], oltre naturalmente alla lunga teoria di uomini di lettere messi in ordine su un immaginario albero genealogico dei maestri.
A minha lista, com a respectiva fundamentação, foi esta: Luís de Camões, porque, como escrevi no Ano da Morte de Ricardo Reis, todos os caminhos portugueses a ele vão dar; Padre António Vieira, porque a língua portuguesa nunca foi mais bela que quando ele a escreveu; Cervantes, porque sem ele a Península Ibérica seria uma casa sem telhado; Montaigne, porque não precisou de Freud para saber quem era; Voltaire, porque perdeu as ilusões sobre a humanidade e sobreviveu a isso; Raul Brandão, porque demonstrou que não é preciso ser-se génio para escrever um livro genial, o Húmus; Fernando Pessoa, porque a porta por onde se chega a ele é a porta por onde se chega a Portugal; Kafka, porque provou que o homem é um coleóptero; Eça de Queiroz, porque ensinou a ironia aos portugueses; Jorge Luis Borges, porque inventou a literatura virtual; Gogol, porque contemplou a vida humana e achou-a triste.[3]
Si tratta di un’ammissione di paternità importante e forse di un vero e proprio passaggio di consegne, perché questi grandi intellettuali, ricordati qui con affetto, hanno esercitato un influsso innegabile e condizionato il processo creativo del futuro Premio Nobel. Nel corso della nostra analisi ci siamo imbattuti nei loro nomi, cercando di assegnare a ciascuno il peso che ebbe nella ricerca di un’identità e riconoscendo vari gradi di influenza, che se per alcuni è evidente, come per Luís de Camões e Fernando Pessoa (i quali sono addirittura i protagonisti di una pièce e di un romanzo), per altri è più nascosta, ma se si pensa a Padre Vieira, Raul Brandão ed Eça de Queiroz, il loro apporto è imprescindibile. Saramago sale sulle spalle di questi giganti per proseguire la loro missione di rinnovare la letteratura, pur mantenendo una propria rotta e dei suoi obiettivi. È per questo spirito di indipendenza che Saramago non rientra del tutto tra i neorealisti, tra i simbolisti e neppure tra gli esponenti del cosiddetto realismo magico. Di queste correnti egli studia e applica solo alcune caratteristiche, salvo poi superarle e passare ad altro. La sua vicinanza al neorealismo dura, infatti, lo spazio di un paio di romanzi e di qualche poesia, mentre la fase simbolista si irradia solo in certi lavori (Os Poemas Possíveis, Provavelmente Alegria), traducendosi poi in allegoria. Per quanto riguarda il realismo magico, invece, la questione è più difficile, perché pur essendo evidenti i richiami alle suggestioni della letteratura sudamericana, sorella di quella iberica a cui Saramago deve molto, tale filone è apertamente visibile solo in qualche racconto, rimanendo però un nucleo narrativo latente e mai completamente espresso (si pensi al racconto Embargo in Objecto Quase e ai romanzi A Jangada de Pedra e As Intermitências da Morte). Tutto ciò da un lato conferma la duttilità di uno stile che non risulta impermeabile agli influssi e che denota una certa capacità di sfruttare gli spunti di ciascun movimento per espandere la propria policromia; dall’altro ribadisce però la volontà di restare autonomo dai monopoli culturali e dalle etichette affibbiate dalla critica, tradendo quindi il bisogno di realizzarsi con le sue forze.
Dopo aver tracciato brevemente il quadro degli influssi e viste quali erano le sue aspettative alle soglie della maturità, ciò che Saramago aggiunge di suo, una volta entrato nella cerchia dei più grandi, è senza dubbio la sua visione sociale della letteratura. Se l’esperienza fatta durante il periodo di formazione gli era servita per acquisire un suo stile, la fase matura diventa il trampolino di lancio per rielaborare in altri termini il bagaglio di competenze umane e culturali accumulato nei decenni precedenti. Non si potrà mai intendere a fondo Saramago se ci si ostina a tenere separati i due aspetti, quello umano da quello letterario, o a ritenere forma e stile due entità separate, inserite in una bolla metafisica isolata e scollegata dal mondo reale. Saramago è invece tra gli autori più reali e politicamente concreti della sua generazione, poiché nella sua idea di letteratura egli pone al centro l’essere umano, di cui si nomina alfiere, per restituirgli la dignità da cui è stato spogliato (da dittature, guerre, carestie, analfabetismo e sfruttamento). Infatti, per lo scrittore insignito dall’Accademia Svedese, ma ancor di più per il ragazzo cresciuto nel cuore più povero del Portogallo, l’uomo di cui bisogna parlare è colui che ha patito la fame e la miseria, chi non ha potuto studiare – rischio corso dallo stesso Saramago – ma che ciononostante è ancora capace di atti di umanità verso il prossimo, a cui sa parlare con semplicità, non quindi con il linguaggio astruso delle università o, peggio, con quello becero del potere. Saramago scrive principalmente per costoro quando afferma che è suo dovere restituire una voce a coloro che una voce non l’hanno mai avuta. Mosso da questo credo, egli inventa uno stile che riproduce il parlato degli umili, in grado di rendere le tonalità volatili e spontanee dei discorsi che si fanno all’aperto, in piena campagna, spazzati dal vento come nelle vaste pianure portoghesi. Tale linguaggio prende per la critica il nome di oralità, perché pur essendo nella sua destinazione un messaggio scritto, suscita in chi lo legge la sensazione di trovarsi in presenza di qualcuno che stia raccontando una storia. Alla base dell’effetto uditivo, appunto ‘orale’ del racconto, c’è la felice congiunzione tra l’armatura ortografica dei testi a stampa, spolpata e ridotta a due soli segni grafici (il punto e la virgola), e una vena narrativa dirompente che cerca di trascinare con sé tutto quanto. Il risultato di queste due spinte è un testo che si avvicina ben più alla musica che alla letteratura, nel suo avanzare ritmato, simile al suono prodotto dalle note su uno spartito. Ne era consapevole l’autore, il quale proponeva di immaginare la lettura dei suoi romanzi come l’esecuzione di una melodia e quindi suggeriva di recitare mentalmente il testo, se non di leggerlo a voce alta. Ma al fondo questo modo di scrivere rimane la conseguenza del suo umanitarismo, l’inevitabile espressione del bisogno di parlare di certi argomenti dai quali non si può torcere lo sguardo. Per queste ragioni nascono Terra do Pecado, Claraboia, Manual de Pintura e Caligrafia, Levantado do Chão, Memorial do Convento, Ensaio sobre a Cegueira, Todos os Nomes, A Caverna e altri. José Saramago descrive la mestizia dell’uomo qualsiasi, le cui poche aspirazioni si infrangono contro una società monocroma, da cui viene accettato solo in qualità di lavoratore e di membro silenzioso dei suoi ingranaggi. Quando costui si discosta o sovverte l’ordine imposto dall’alto, allora la società lo espelle disumanamente, chiudendolo fuori dalle sue porte. Tutta la sua bontà è pertanto destinata ad esprimersi altrove, spegnendosi in un volo della fantasia o librandosi in un atto di eroismo che nessuno, forse nemmeno chi scrive, si aspettava. L’impellenza dell’autore rimane comunque la redenzione dell’uomo. Con i suoi libri egli cerca di rimediare ai torti subiti dalla fetta più debole dell’umanità, quella travolta da una società alienante, divisa da una religione vendicativa e oppressa barbaramente dal potere. Attraverso la scrittura, e con la complicità del lettore, i personaggi saramaghiani galleggiano in un universo diverso dal nostro, privo di nomi, di date e di luoghi – ecco la maschera dell’allegoria – ma che sanno dialogare con il mondo esterno in maniera sottile e ironica. Si avverte la necessità dell’allegoria nell’ipotesi costitutiva del racconto, quando si considera che qualunque discorso intorno all’uomo, per raggiungere valori universali, deve perdere i suoi elementi non essenziali, farsi opaco e indistinto. In tal senso, il racconto non deve limitarsi a descrivere una sola situazione e un’unica linea temporale. Soltanto il racconto anonimo potrà rispecchiare il destino dell’uomo di ogni tempo. Questo tra l’altro spiega perché Saramago abbia abbandonato il neorealismo dopo appena due romanzi: lo riteneva insufficiente a fini di un discorso generale, come egli voleva. Il lettore però non viene lasciato da solo a chiedersi se la sua interpretazione sia giusta. Per guidarci verso lo scioglimento del simbolo, l’autore inserisce formule stereotipate e segnali verbali riconoscibili da chiunque, disseminati ad esempio nel gergo della propaganda e in quello delle riunioni di gabinetto, come nel caso dei due Ensaios. Viste da vicino, queste allusioni non richiedono infatti di puntare il dito verso un’epoca in particolare, dato che si tratta di meccanismi appartenenti a tutte le epoche.
Il linguaggio è la seconda grande invenzione che, insieme al suo sincero umanitarismo, regge sulle spalle l’intero edificio della nostra esegesi. Per Saramago la lingua è lo strumento con cui riflettere le più piccole sfumature di significato. La sua attenzione si concentra tutta sul passaggio da un registro all’altro, dal rispetto della semantica e della sintassi fino al loro sconvolgimento, visibile già dai primi tentativi. Giocando con gli stili, egli persegue una gematrìa originale che deve rispondere prontamente alle improvvise mutevolezze del pensiero. Nella sua idea di letteratura il linguaggio è il mezzo con cui ristabilire gli errori della nostra scala gerarchica secondo criteri morali e non di censo, dove in cima si trovano i semplici e in fondo, meritatamente, i potenti. Egli rovescia da par suo le ingiustizie, facendosi restauratore della perduta grandezza d’animo secondo gli stessi principi di umanità presi a modello per forgiare i suoi personaggi. Nel suo carnevale linguistico e pluristilistico gli uomini còlti parlano con serietà ma fanno ridere, mentre gli analfabeti, che non ambiscono alle finezze dei primi, si esprimono sobriamente ma con una saggezza da filosofi. Saramago ricrea con il linguaggio un’immagine positiva della società, finalmente giusta, nella quale – come si è visto – lo stile segue fedelmente il contenuto mentre la materia puntella la forma dall’interno. Saramago è inoltre attratto dalla parola arcaica e dalla citazione erudita, pur coniando una serie sterminata di detti popolari, quasi a volersi distaccare dall’enciclopedismo ufficiale per creare un suo sapere, nobile quanto quello delle persone istruite (ci si ricordi che Saramago era autodidatta) ma di estrazione contadina, perciò più vicino alla propria. La rivalsa si estende dunque alla parola e in senso lato alla forma, che è pertanto l’altra faccia del suo politicismo radicale. Ciò che troviamo nello stile completa ai nostri occhi l’immagine di uno scrittore schierato in difesa dei più deboli, la cui passione per le lettere emana la stessa forza delle sue idee politiche. Lo stile accompagna il pensiero, nella stessa misura in cui il pensiero arricchisce lo stile, impegnandosi reciprocamente ad esprimere la voce di coloro le cui «vidas desperdiçadas» sarebbero state altrimenti inutili. In tal senso i concetti di espressione totale e di «prazer digressivo», analizzati nelle pagine centrali di questo lavoro, laddove costituiscono la cifra più riconoscibile della scrittura romanzesca, alla luce delle loro ricadute sociali acquisiscono dei connotati profondi, non più squisitamente linguistici, ma intimamente legati alle sue convinzioni. Seguendo questa traiettoria morale, lo scrittore riproduce a livello testuale ciò che lo muove umanamente e lo fa allargando le maglie dello stile, per cui quello che sembra incontinenza verbale altro non è se non il tentativo di esperire, anche sul piano narrativo, con digressioni e commenti diretti le innumerevoli direzioni offerte dalla trama. Se l’oralità era l’unico modo di scrivere senza snaturare il senso di quelle vite sprecate, rimaste tenacemente lontane dalla cultura libresca, così egli spera di dire tutto quello che c’è da dire su costoro, prima di dargli il dovuto riposo. Inoltre, dall’analisi della lingua possiamo seguire da vicino il cambiamento che si produce nell’ultimo periodo (da As Intermitências da Morte in poi), quando Saramago sembra aver perso anche l’ultimo briciolo di fiducia nelle possibilità redentive del genere umano, che aveva immaginato possibile fino a non molto tempo prima, attraverso il senso innato di bontà e semplicità incarnato dai suoi personaggi. Da allora lo stile subisce una decisa flessione verso toni marcatamente sarcastici, più dark che in passato, e viene meno anche il piacere per la divagazione che aveva giocato un ruolo fondamentale nell’architettura narrativa generale. L’ultimo narratore è un narratore linguisticamente freddo, isolato dal suo lettore, con cui comunica soltanto tramite la catena dei suoi ricordi, dai quali possiamo risalire ad alcuni nuclei mitopoietici che trovano ora una spiegazione nel passato dell’autore. In questo senso, le fiabe e il candore con cui sono scritte le memorie di As Pequenas Memorias, tutte opere linguisticamente lineari e geologicamente scarne, ci offrono dal canto loro i tasselli per completare il quadro globale. Si conferma con gli ultimi lavori l’assioma secondo cui con l’avanzare dell’età l’uomo acquista finalmente il diritto alla semplicità. Il panorama ci sembra tranquillo e l’affresco completo. Prima di lasciargli poggiare la penna, vorremmo ricordare una mezza pagina di diario risalente al 1993, dove Saramago si interrogava sulla parte del cammino già percorsa e rispondeva con ingenua fiducia a una delle sue più grosse preoccupazioni, quella di non aver detto ancora tutto.
Nos Poemas
Possíveis, que foi publicado em 1966, aparecem uns versos – «Poema a boca
fechada» – escritos ainda nos anos 40 e conservados até àquela altura por uma
espécie de superstição que me impediu de lhes dar o destino sofrido por tantos
outros: não o cesto dos papéis, pois a tanto não chegavam os meus luxos
domésticos, mas, simplesmente, o caixote do lixo. Desse poema, as únicas
palavras aproveitáveis, ou, para dizê-lo doutro modo, aquelas que o puseram a
salvo da tentação destruidora, são as seguintes: «Que quem se cala quanto me
calei / não poderá morrer sem dizer tudo.» Sobre o dia em que elas foram
escritas passaram quase cinquenta anos, e se é certo lembrar-me ainda de como
era o meu silêncio de então, já não sou capaz de recordar (se o sabia) que tudo
era aquele que me iria impedir de morrer enquanto não o dissesse. Hoje já sei
que tenho de contentar-me com a esperança de ter dito alguma coisa.[4]
[1] «Foi isso que me levou a esse sentido da História, que para mim era confuso, mas que depois vim a entender, em termos mais científicos, a partir do momento em que descobri uns quantos autores (os homens dos Annales, os da Nouvelle Histoire, como o Georges Duby ou o Jacques Le Goff), cujo olhar histórico ia por esse mesmo caminho.» (C. Reis, Diálogos, p. 85).
[2] Su Herculano: «[…] provavelmente o maior, historiador português […], que decidiu também escrever romances históricos, e há três romances, O Monge de Cister, Eurico o Presbítero e O Bobo, romances que hoje não é fácil ler, romances escritos num estilo muito, diria eu, muito pesado, um estilo, que digamos, não avança, onde há uma retórica romântica dificilmente suportável. De toda a forma, são enfim livros duma grande intensidade.» (A Estatua e a Pedra).
[3] J. Saramago, Cadernos de Lanzarote Diário IV, Caminho, p. 179,
[4] J. Saramago, Cadernos de Lanzarote, Diário-I, p. 78.

RINGRAZIAMENTI
Pochi mesi prima del ventesimo anniversario dal Nobel del 1998, Pilar del Río, vedova di José Saramago, rinvenne casualmente nel computer con il quale erano stati scritti gli ultimi romanzi, un sesto quaderno di Lanzarote. Prima si pensò a uno scherzo, poi, validato il ritrovamento, subentrarono inevitabilmente l’emozione e la commozione, data la ricorrenza che ci si preparava a festeggiare. Pochi si ricordarono che Saramago, nel II Caderno di Lanzarote aveva anticipato che i diari, il cui nome voleva essere un omaggio all’isola su cui si era trasferito da poco, sarebbero stati sei e non cinque. Nessuno si aspettava che quella promessa si trasformasse alla fine in realtà, anche perché l’agenda di quegli anni era fitta di impegni, man mano che la sua popolarità cresceva. La fama era diventata ormai celebrità. Tutte le università lo volevano. Saramago era sballottato in giro per il globo, pur essendo già ultrasettantenne, a tenere conferenze e c’era sempre qualche nuova opera in cantiere. Per questo nessuno si azzardò a rinnovare il ricordo di quella promessa. Ma Saramago evidentemente non se n’era dimenticato. Tra un’intervista e una bozza da rivedere, una cena di gala e l’inaugurazione di qualche museo, riuscì a ritagliarsi degli spazi (a volte a distanza di settimane) per raccontare i mesi precedenti la fatidica telefonata di Stoccolma. Grazie alla tenacia e alla disciplina che l’avevano accompagnato per tutta la vita, Saramago ci regala uno straordinario racconto postumo dei suoi ultimi mesi da scrittore non ancora insignito della massima onorificenza letteraria, fino agli ultimi giorni di quel lontano 1998. L’anno precedente Saramago si era dovuto rassegnare a un’ennesima delusione, quando il Nobel lo vinse Dario Fo, col quale però Saramago si congratulò sinceramente. Dario Fo riconobbe quanto la sua vittoria fosse stata inaspettata e quasi si scusò di averlo privato di quel prestigioso riconoscimento. Saramago chiuse la vicenda schermandosi dietro la sua proverbiale modestia. Egli riteneva già la sua carriera di scrittore un frutto inaspettato, giunto tra l’altro in un’età in cui di solito si tirano le somme e non ci si avventura in una nuova vita come aveva fatto lui. Tuttavia Saramago, nelle confidenze affidate ai quaderni, lasciò trapelare qua e là il desiderio di essere chiamato a Stoccolma, pur non esternandolo mai direttamente. Fu solo questione di tempo. Probabilmente Saramago in quel sogno ci credeva, altrimenti non avrebbe scritto un sesto diario, all’insaputa perfino di sua moglie.
Il ritrovamento di un sesto diario è avvenuto tra l’altro quando mi accingevo a scrivere le ultime pagine di questo lavoro, basando le mie conclusioni soltanto sui contenuti dei primi cinque quaderni. Come ho già detto nella prefazione, il ringraziamento più grande va a Saramago, per avermi fatto avvicinare alla lingua portoghese. La sua opera è stata la porta dalla quale sono penetrato in un mondo che non conoscevo, antichissimo come l’ombra di quelle navi che sono partite alla ricerca di nuovi mondi. Saramago è insieme a Camões e Pessoa il figlio più amato del Portogallo. La forza delle sue parole si staglia sullo sfondo di un paese geograficamente ai bordi dell’Europa, dalla cui lingua però si vede il mare (per parafrasare Virgílio Ferreira) e al contempo al centro di vicende di fondamentale importanza per la nostra identità storica. L’amore per quella gente e per quella lingua è il suo lascito più grande, un lascito che non tramonterà, come non può tramontare la riconoscenza dei suoi lettori, tra i quali io mi onoro di sedere. Oltre a Saramago mi preme ringraziare alcune persone che ho incontrato in questo cammino. Su tutte Pilar del Río, che ho conosciuto proprio in occasione del lancio del sesto diario, edito per il ventennale con il titolo speciale El cuaderno del año del Nobel (accompagnato da un secondo volume, Un país levantado en alegria, dove sono state raccolte le impressioni dei cittadini e della stampa portoghese alla notizia della vittoria del Premio Nobel da parte di uno scrittore di lingua portoghese). Pilar è una donna eccezionale e di straordinario carisma, che dopo la scomparsa di colui che è stato suo compagno di vita, si è dedicata a trasmetterne con incredibile capacità comunicativa il messaggio umano, prima ancora che letterario. Grazie a Pilar, noi tutti possiamo sentire ancora vicino l’autore di Levantado do Chão e del Memorial do Convento, come se fosse di là, nel suo studio, impegnato con un nuovo libro.
Insieme a Pilar, la mia riconoscenza va a Ricardo Viel, vicedirettore della Fundação José Saramago di Lisbona, per essersi interessato al mio lavoro e per avermi fornito le chiavi di lettura migliori dei primi romanzi (quelli del cosiddetto periodo formativo). Vorrei coinvolgere anche Leticia, volto solare della Casa José Saramago in Lanzarote, e tutti i volontari – ma è più corretto parlare di famiglia – che si preoccupano di accogliere coloro che, passando da Lanzarote, visitano la casa di Saramago, per passione o per semplice curiosità, e a cui non mancano mai di offrire un caffè (come avrebbe voluto José).
Un grazie va anche a chi, più o meno direttamente, ha influito sulla decisione di trattare questo argomento, in questo modo, cioè alla traduttrice “ufficiale” di Saramago in italiano, Rita Desti, al professor Vincenzo Russo, mio relatore, e ai volontari della Fondazione Saramago di Lisbona, e in generale a chiunque mi abbia fatto dono di un ricordo personale di Saramago. Tra questi, un ricordo per me prezioso mi è stato regalato dal professore Padre Luigi Pellegrini, dell’Ordine dei Frati Minori, con cui ho avuto il privilegio di conversare di religione e di Saramago nell’estate del 2014, ai piedi del Monte Subasio, sotto la magnifica ombra di Assisi. A lui devo l’insegnamento che la scrittura adempie veramente il suo compito quando accende una scintilla che possa illuminare un cammino comune a uomini che vengono da strade distinte. La cosa più difficile è non lasciare che la stessa fiamma, su cui Saramago soffiava per risvegliare le coscienze, non per imprigionarle, diventi invece un muro invalicabile, perché così ci rimettiamo tutti.
Premetto che il così detto ateismo mi pare sempre un atteggiamento “di facciata”, perché mi sembra che al fondo rappresenti il rifiuto di una certa immagine di Dio: quella corrente anche in troppe raffigurazioni all’interno della chiesa e da parte dei suoi “ministri”. Nel caso specifico di Saramago si tratta del rifiuto di un Dio vendicativo e sanguinario. Basti pensare proprio all’ultimo romanzo Caino e soprattutto alla conclusione, messa in bocca al demonio, del lunghissimo colloquio tra Cristo e Dio sul lago di Genezaret: «Bisogna proprio essere dio per aver tanta sete di sangue». Non si fa fatica a condividere tale presa di posizione e a pensare e credere in un Dio alternativo che non ha bisogno del sangue né degli uomini, né degli animali; semmai invita a non spargere sangue innocente: così in tanti passi della Bibbia, compreso l’Antico testamento, e soprattutto il Nuovo. Perciò ritengo non abbiano senso certe prese di posizioni, più o meno ufficiali della chiesa, compreso quanto scritto sull’Osservatore romano in occasione della morte dello scrittore portoghese, di cui ho apprezzato e goduto della lettura di diversi romanzi.
C’è un altro atteggiamento di Saramago nei confronti delle modalità correnti di praticare e “utilizzare” la religione. Basta leggere l’introduzione alla pièce teatrale su s. Francesco; «È noto quanto i veri atei siano scrupolosi in materia di etica religiosa, come al loro spirito ripugnino le offese contro una trascendenza che essi rifiutano ma che vogliono vedere integralmente rispettata da coloro che per missione e devozione devono proclamarne le virtù e i meriti. È comprensibile, dunque, che la visione in un chiostro del convento, dietro un bancone, di due francescani che, in tonaca e cordone, vendono rosari, statuine, stampe, libri edificanti, statuine, scapolati, crocifissi, insomma tutta quella chincaglieria che del cattolicesimo nella peggiore delle sue versioni, che è quella superstiziosa, abbia ferito profondamente qualcuno che, senza rendersene conto, si aspettava di trovare ad Assisi un segnale perenne del passaggio luminoso di san Francesco nella vita terrena. Pensò allora che quei frati, non essendo più nella condizione di mendicanti, non avrebbero dovuto continuare a chiamarsi proprio così, francescani, giacché la fatica dei secoli e il cambiamento dei costumi tanto radicalmente avevano sovvertito la regola instaurata dal fondatore. Quelli che prima chiedevano, adesso vendono, quelli che prima rinunciavano, adesso accumulano. Perciò Francesco d’Assisi ritornerà nel mondo per restituire all’Ordine la sua originaria purezza. Confermerà quanto già sapeva, che la ricchezza è sempre infame, ma imparerà a proprie spese che è un errore contro la carne e contro lo spirito fare della povertà condizione per accedere al cielo…». Il pezzo su Francesco non è dei migliori, pur se consequenziale a tale introduzione, ma vi sono ben altri testi dell’autore che andrebbero letti e sui quali varrebbe la pena riflettere, anche per quanto riguarda l’idea stessa di Dio…
20 febbraio 2015, Padre Luigi Pellegrini, ofm.
L