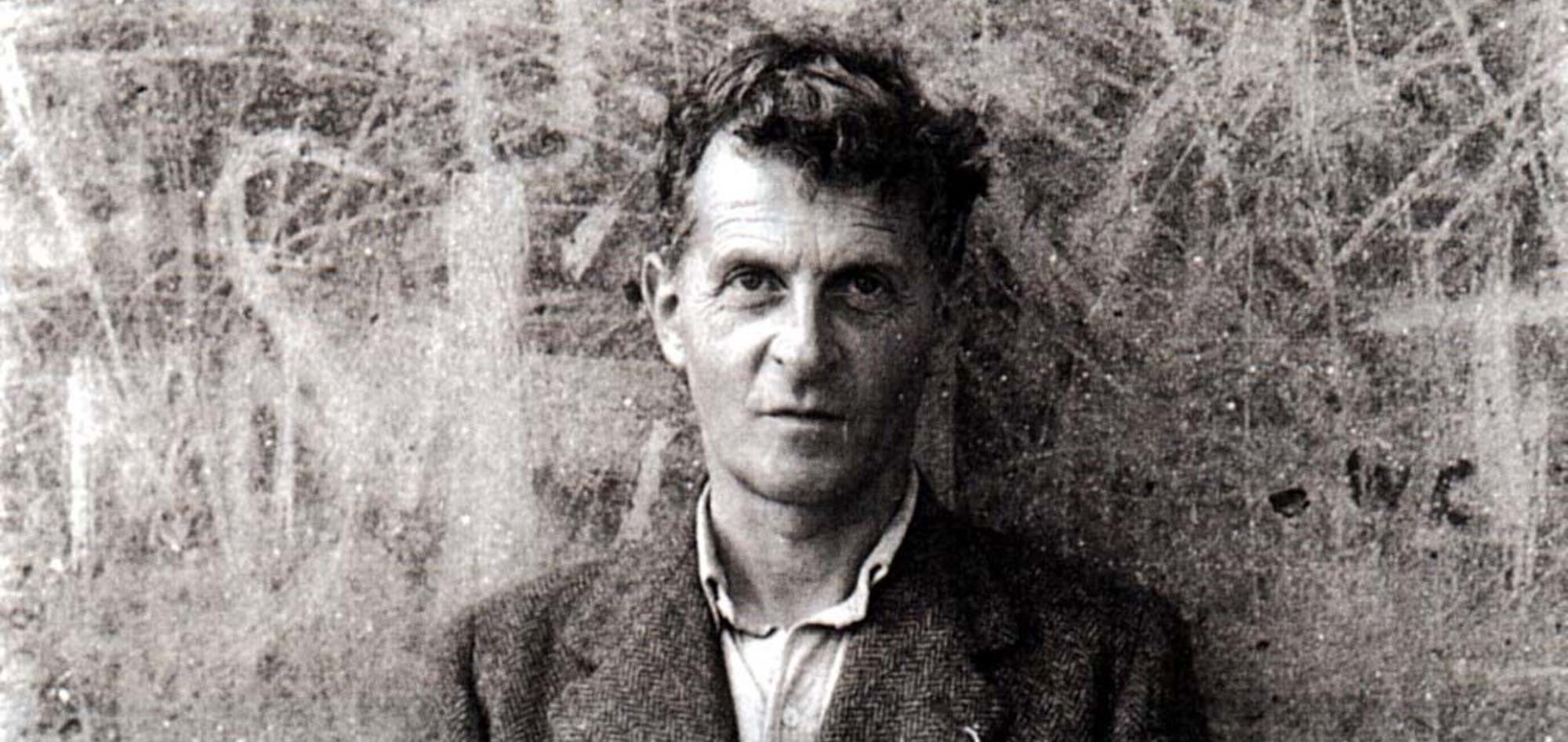Quando mi immergo nelle pagine di Bufalino ne ricavo sempre un piacere salmastro, istrionico e ancestrale, che mi rimane addosso per anni. Il suo stile inconfondibile, quel linguaggio avvolgente, il mondo barocco e un po’ malinconico mi appagano come un tuffo in una grotta scavata dal mare, dove la luce che filtra appena si frastaglia prima sul chiaroscuro dell’acqua e poi illumina debolmente il fondale, stesi sul quale riscopro tesori che non sapevo perduti. Per me leggere Bufalino è qualcosa di iniziatico e al contempo misterioso: una ricerca tra le pieghe dell’anima che si conclude sempre con il ritrovamento di me stesso.

Avevo già letto tempo fa Diceria dell’untore, il suo romanzo più famoso, e recentemente Argo il cieco ovvero i sogni della memoria e Il malpensante, lunario dell’anno che fu, libri purtroppo meno conosciuti rispetto al primo ma ugualmente belli. Vinto in partenza dall’eleganza dei titoli di un autore che ha raggiunto la notorietà solo al tramonto della sua vita, mi sono accorto di avere di fronte a me soltanto l’imbarazzo della scelta e giacché la voglia di ritornare al maestro si era fatta prepotente, ho optato alla fine per Le menzogne della notte (vincitore tra l’altro del Premio Strega nel 1988) dalla cui lettura ho tratto – c’era da dubitarne? – un diletto a dir poco viscerale.

Le menzogne della notte è un libro particolare, partorito probabilmente come il Frankenstein di Shelley, in una notte di tempesta. Narra di un gruppo di quattro uomini, arrestati con l’accusa di tentato regicidio, deportati su un’isola-prigione sperduta nel Mediterraneo, e in attesa di essere giustiziati. I quattro devono trascorrere in una cella comune la loro ultima notte e il racconto di Bufalino ripercorre proprio quella manciata di ore, lunghe eppure fuggevoli, facendosi per noi testimone silenzioso delle loro confidenze e messaggero fedele di ciò che, per motivi diversi, li ha portati a ordire un assassinio. La storia, così impostata, mi ha ricordato fin da subito le ambientazioni de Il conte di Montecristo di Dumas e L’Ultimo giorno di un condannato a morte di Hugo, ma le analogie con l’Ottocento, letterario e storico, sono tante e affollano numerose le paginette di questo straordinario racconto. Da Dumas Bufalino si è forse lasciato influenzare per l’immagine del Castello-fortezza di If e da Hugo avrà tratto lo spunto per la confessione in prima persona, “a favore di telecamera”, di un condannato a morte. Tuttavia, è Bufalino stesso che in quarta di copertina ammette le influenze e paga i debiti, aiutandoci così a percorrere meglio il testo e a decifrarne i tantissimi riferimenti, più e meno velati.

I protagonisti come detto sono quattro: Corrado Ingafù, conosciuto come il Barone, Saglimbeni, sedicente poeta, Agesilao, di professione soldato, e lo studente Narciso Lucifora. Ciascuno di loro si trova lì suo malgrado a rispondere dell’accusa di sedizione e attentato alla vita del re, di cui, per un artificio letterario, ignoriamo il nome. E già, perché Bufalino non menziona mai di quale re si tratti, né tantomeno ci dice la dinastia o il periodo storico. Sappiamo soltanto che ci troviamo ad un certo punto della decade ’50 del 1800, dopo i moti insurrezionali di inizio secolo e i successivi rigurgiti antiborbonici. Il contesto geografico è comunque quello del Sud Italia, prima dell’Unità d’Italia e molto dopo le campagne mazziniane. Ognuno dei condannati a morte racconta a turno la propria storia, dopo un paio di capitoli attraverso i quali veniamo introdotti alla cupa atmosfera della prigione e al suo responsabile, Consalvo de Ritis, governatore del carcere e ardente filomonarca. Proprio l’uomo del re apre il racconto sfogliando i dossier di ciascun prigioniero, a cui, prima di lasciare un’intera notte per rifletterci sopra, offre la possibilità di redimersi in extremis, dichiarandosi disposto a salvarli tutti e quattro se almeno uno scriverà all’alba su un foglio il nome del “mandante” della congiura. Fatta la proposta, il governatore si ritira, lasciando i quattro liberi di soppesare l’offerta. Nel frattempo sull’isola cala la notte e, studiatisi reciprocamente con occhio inizialmente torvo e poi via via fraterno, da sodali in armi, i prigionieri si alternano, in un novello Decameron risorgimentale.
I quattro racconti hanno ciascuno un titolo: Il racconto dello studente ovvero Narciso salvato dalle acque; Il racconto del barone; Il racconto del soldato ovvero Il guazzabuglio, Il racconto del poeta ovvero il gallo cieco. La penna di Bufalino è di rara perfezione nella sua capacità di catturare l’intensità emotiva e la temperie culturale dell’epoca, oltre ad essere argutamente ricercata e pacatamente fine. Mai eccessiva, la scrittura è infatti ampiamente lirica, com’era la penna dei grandi scrittori dell’Ottocento. Dietro il racconto, a questo punto cornice di racconti, vi è sicuramente un maestoso lavoro di recupero delle fonti, alla base delle teorie egalitarie che hanno ispirato l’azione immortale di chi ha sacrificato tutto per un ideale e smosso alla ribellione le coscienze di intere generazioni.
E’ impossibile, dietro una suggestione eminentemente linguistica, non cedere alla fascinazione, pur abbellita dal tono romanzesco, delle storie dei condannati e strizzarvi l’occhio. Si sarebbe a un certo punto quasi tentati di giustificare ciò che costoro hanno fatto – o meglio tentato di fare – se non fosse che, racconto dopo racconto, si intravedono nelle loro parole piano piano ombre e si scorgono increspature (rivelatrici in chiusura delle eponime “Menzogne”). Ma ciò che rimane innegabilmente educatore è l’arco a tutto sesto che dal singolo si stende sulle teste degli uomini, della storia particolare che si fa universale, con le considerazioni, quasi a filo di ghigliottina, sugli amori passati, le passioni, politiche e umane, i sogni, i rimpianti, le ebbrezze e le delusioni. Che cos’è in ultima analisi per un patriota, un ribelle, la vita, dinanzi alla purezza adamantina di un principio, qual è quello assoluto della libertà, pur se essa significhi morte?
“Fra i due piatti della bilancia non c’è paragone: su uno sta la luce, la gioventù della luce; il poter dire: io fui, sono, sarò; poter essere ancora un poco un’inconfondibile goccia nel mare dell’esistenza; e abbracciare ancora carni di donne, annusare i fiori, ridere, piangere, dire in ogni momento Io, Io, Io…Tutto questo su un piatto ed ha il peso di una montagna. Mentre sull’altro sta solo un alito d’impalpabile nulla, una tenebrosa patria di tutti, dove le vostre parole: uguaglianza, libertà, fratellanza, che vi sembrano oggi così fatali, non avrete menti per pensarle, mani per scriverle, bocche per dirle…”
Vi è molto altro in questo luminoso capolavoro, di cui però vi lascio intatta la sorpresa. Sperando di avervi incuriositi vi auguro buona lettura.
L