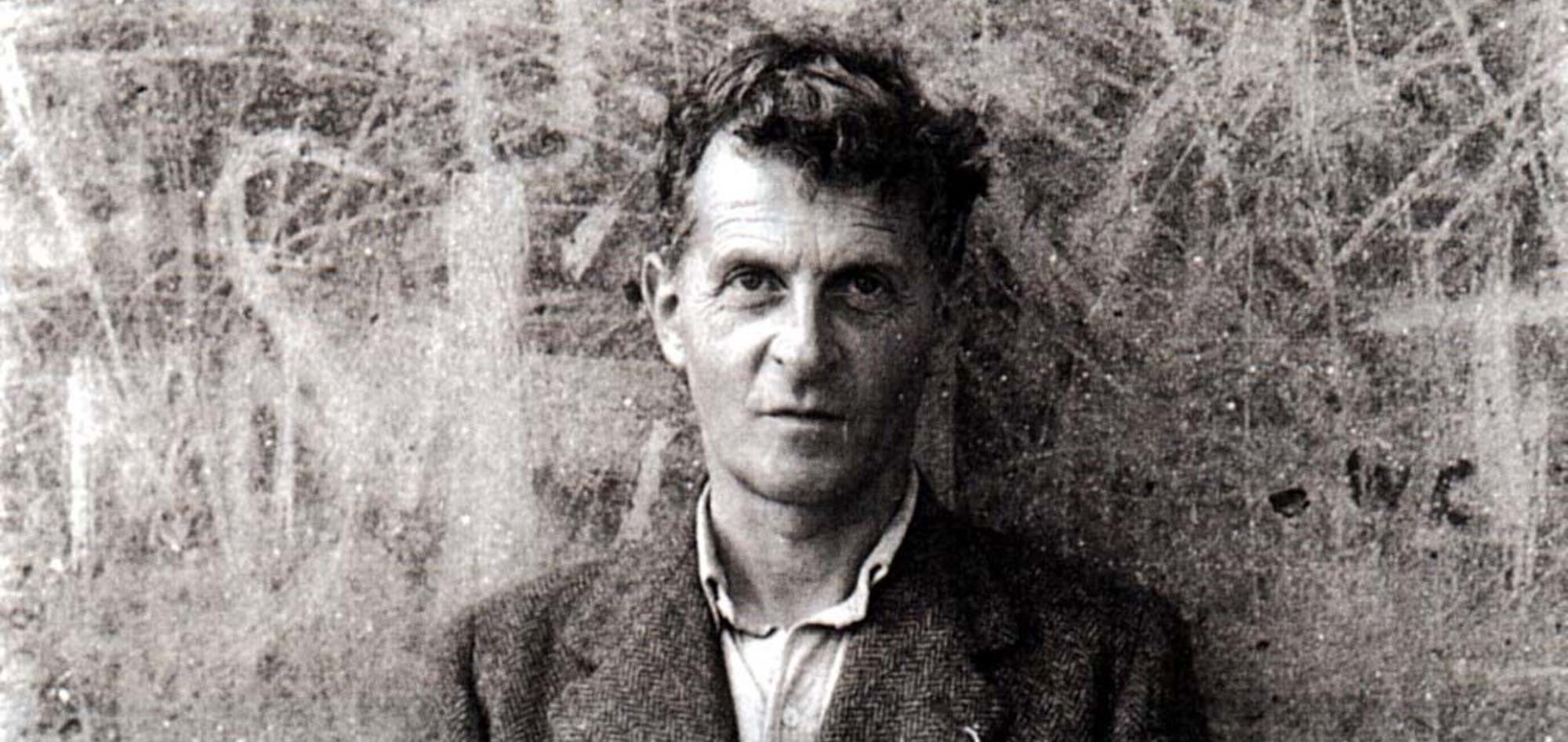Già in questo articolo ho affrontato il delicato argomento della scrittura e ho parlato di quanto sia doloroso il processo creativo. Almeno sulla base della mia esperienza. Ho cercato di riassumere (maldestramente) qualcuno degli errori che più facilmente si commettono nello scrivere un libro (eccessiva preparazione, linguaggio inadeguato, verbosità, incoerenza ecc). Insomma, vedi sopra.
Mi ero ripromesso di soffermarmi su un aspetto che, a mio avviso, è quello intorno al quale ruota tutta la macchina e a causa del quale, molto spesso, un libro ha poco, se non alcun successo: il linguaggio. Vale secondo me la pena spendere qualche parola proprio a proposito del linguaggio e cercare di capire insieme perché il suo uso (più spesso abuso) sia così delicato. Naturalmente, anche quelle che seguiranno sono considerazioni del tutto personali e soggettive, basate su ciò che ho sperimentato di persona.
Dunque, la lingua, inutile ricordarlo, è un muscolo. E come tutti i muscoli, quando manca di esercizio si indebolisce. Parlo chiaramente della lingua nel senso di linguaggio, lessico, sintassi, retorica. Ossia di tutto ciò che si cela dietro l’espressione letteraria, che è poi il modo in cui la nostra voce suona dietro una tastiera.
Ognuno di noi possiede un certo vocabolario, conosce dei modi di dire, ha imparato nel corso del tempo parole gergali, termini arcaici, espressioni dialettali. Alcuni parlano anche altre lingue e hanno quindi immagazzinato a livello profondo del cerebro strutture grammaticali, che possono essere più o meno simili all’italiano. Ad una vasta conoscenza della propria lingua madre (rare sono le persone che scrivono in più lingue), non sempre però corrisponde un’uguale abilità scrittoria. Voglio dire, abbiamo provato tutti la sensazione che la padronanza della nostra lingua ci garantirà, alla prima occasione, di scoprirci grandi romanzieri e parolieri dalla penna facile e, perchè no, potenziali Premi Nobel. Posso dirvi, senza tema di smentita, che non è così.
La prima cosa che si prova, di fronte a una pagina vuota, è la paura. “Oddio, e ora da dove comincio?“. Così iniziamo a digitare qualche parola. Cerchiamo di mettere insieme una frase a casaccio, nella speranza che la pagina si riempia da sola. Ci auguriamo che una parola tiri l’altra e che, a poco a poco, il discorso fili da sé, in una sorta di flusso di coscienza. Calma, di Joyce ce n’era uno solo. Subentra allora lo sconforto. Ci ritroviamo bloccati, inermi. Non sappiamo cosa e dire e soprattutto non sappiamo come dirlo. Non ci accorgiamo che, forse, i nostri balbettii non dipendono da vaghi ricordi degli esercizi di analisi logica e dal fatto che nell’ultimo anno non abbiamo letto abbastanza libri.
L’errore è piuttosto non avere chiaro in testa l’argomento, ciò di cui si vuole parlare, perché ci concentriamo solamente sulla forma. Senza il concetto, inevitabilmente la forma ne risente. La speranza che la forma preceda il contenuto è assolutamente vana. Un adagio a cui mi sono sempre ispirato è REM TENE, VERBA SEQUENTUR, che può essere tradotto in italiano come «possiedi l’argomento e le parole seguiranno», e che viene attribuito a Catone. Mi pare illuminante. Prima pensa alla trama, a ciò che vuoi mettere in quella pagina bianca e poi vedrai che le parole appariranno (più o meno) da sole.
Ti sei poi chiesto che tono e che stile vuoi adoperare? Stai pensando di scrivere un giallo. Bene, hai esperienza in merito? Sai che tipo di linguaggio ci vuole? Ad ogni libro corrisponde un certo linguaggio. Evitiamo la tentazione di sovvertire il canone. Prima facciamoci le ossa con le regole e poi forse saremo pronti per scrivere come Palazzeschi e Marinetti. Ma dobbiamo conoscere intanto gli stili di ciascun genere. Il consiglio che avevo dato nel mio precedente articolo era di “rubare” ai grandi romanzieri, per esempio il loro modo di costruire la frase. Ovviamente, intendo rubare in senso buono. Non sto invitando al plagio. Usano frasi corte o lunghe? Termini di tutti giorni o manzoniani?
Io, personalmente, faccio molta attenzione alla punteggiatura, alla disposizione dei punti, delle virgole, dei punto e virgola, dei due punti. Di tutto. Mi concentro sulla scorrevolezza delle frasi e sul modo in cui si collegano tra loro (paratassi, ipotassi). Cerco di mettermi nei panni del lettore, per capire l’effetto che il mio paragrafo fa negli occhi di chi legge. Ho da poco scritto un giallo e mi sono reso conto che, per esempio, è meglio adoperare frasi brevi, a effetto, con un buon numero di parolacce e modi di dire colloquiali. Vanno benissimo. Magari stonerebbero in un saggio, ma per un giallo non c’è problema. Anzi, fanno atmosfera. Avevo in mente i classici (Conan Doyle, Poe, Agatha Christie, Simenon) ma anche gli autori “alternativi” (Palaniuk, Pinketts). Ogni genere ha il suo stile, e di conseguenza il suo linguaggio.
Un’altra grande difficoltà, almeno per me, è stata “tornare” a scrivere in italiano. Ho vissuto cinque anni all’estero. Perciò l’italiano in quel periodo mi è servito poco. Mi ero abituato a comunicare soltanto in inglese. Quelle poche volte in cui scrivevo qualcosa, si trattava perlopiù di email di lavoro, ed erano scritte in inglese. Avevo accantonato l’italiano. Questa lontananza l’ho pagata cara quando mi sono finalmente messo a scrivere un libro. Avevo perso familiarità con la mia lingua madre. Molte volte, specie all’inizio, mi trovavo a pensare alla frase in inglese – anche la singola parola – e a non ricordare l’equivalente in italiano. Mi sono sentito frustrato perché ho sempre creduto di possedere un buon lessico, avendo sempre letto e studiato molto. Ma è stato come rimettersi a correre dopo un lungo periodo di inattività. Le frasi che mi uscivano erano rachitiche, lessicalmente povere, costruite male. Ho dovuto perciò fare delle prove. Rileggere libri che avevo già letto, riabituarmi a ciò che era sepolto da qualche parte nella mia testa, ma che non avevo più usato. L’esercizio continuo, giornaliero è stato sì doloroso ma alla fine appagante.
Chi scrive bene è perché ha scritto tanto. Bisogna continuare a scrivere, senza mai fermarsi. Bisogna testare ogni giorno le proprie competenze. Un concetto fondamentale è: creati il tuo linguaggio. Scopri che cosa sai scrivere bene. Testa gli avverbi, le locuzioni. Non avere paura di dire o scrivere qualcosa. Usa il bagaglio di conoscenze che hai, fin nel più minuscolo dei suoi elementi. E’ un po’ come avere una cassetta degli attrezzi e non aprirla mai. Il linguaggio è uno strumento, composto da viti, rondelle, bulloni, che a seconda di come vengono messi insieme, danno luogo a un risultato. La dimestichezza con questi “pezzi” viene solo dalla pratica. Gli anglosassoni dicono infatti PRACTICE MAKES PERFECT. La pratica rende perfetti. True.
Sicuramente il discorso potrebbe continuare ancora a lungo ma, come direbbe qualcuno, «Fa freddo nello scriptorium, il pollice mi duole. Lascio questa scrittura, non so per chi, non so più intorno a che cosa: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.».
L